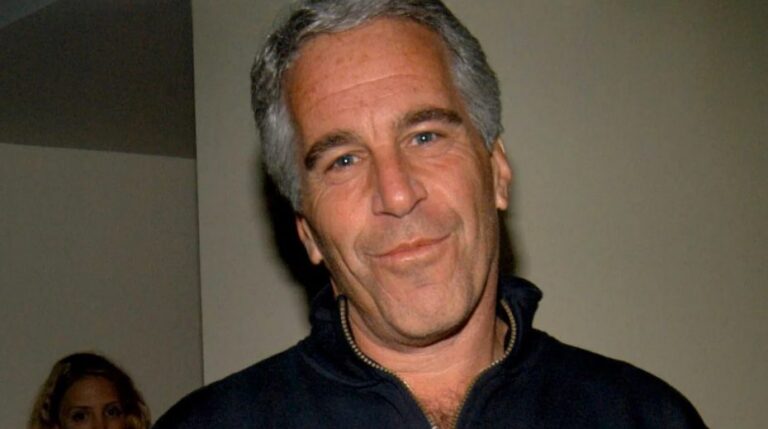La conoscenza della storia e delle idee che hanno portato alla nascita dello Stato greco moderno è limitata. In questo articolo (diviso in due parti) verrà evidenziato il percorso politico peculiare di una nazione che, tra alti e bassi, continua a svolgere un ruolo fondamentale nella geopolitica del Mediterraneo.
Parlare della storia della Grecia contemporanea significa inevitabilmente fare riferimento all’opera fondamentale di Konstantinos Paparrigopoulos (1815-91), “Storia della nazione ellenica”. Lo storico e nazionalista greco, adottando la lingua “dotta” katharevousa (l’italiano “puristica”), sottolinea la continuità identitaria, spirituale e ideale del popolo greco dalla classicità fino al XIX secolo. Tale lavoro si pone in netta contrapposizione alle tesi di Jacob P. Fallmerayer, storico austro-germanico, che invece vedeva i moderni greci come slavi in parte albanesizzati.
Inoltre, Paparrigopoulos mette in luce come la costruzione dello Stato greco e la guerra di indipendenza fossero ispirate dall’idea di un’unità che includesse tutte le comunità elleniche sparse nell’Impero ottomano, espressa nella cosiddetta “grande idea” di unire queste comunità sotto un’unica entità politica greca. A suo avviso, la grecità poggiava essenzialmente su due aspetti fondamentali: la fede ortodossa e la lingua, che per secoli ha rappresentato un elemento di spicco nei rapporti commerciali all’interno dell’Impero.
Nonostante questi ideali condivisi dalle diverse comunità greche, al momento dell’indipendenza la società nel nuovo Stato greco mantenne una struttura ancora premoderna, definita da Ernest Gellner come “società segmentaria”; una realtà basata sul familismo, sulla difesa della comunità rispetto all’autorità centrale e su forme innaturali di clientelismo.
I leader greci post-indipendenza tentarono a lungo di superare tale sistema imponendo modelli di governo centralizzati ispirati all’esempio francese, come nel caso di Kapodistrias o Mavrocordatos. Tuttavia, si scontrarono con una tradizione fortemente conservatrice, accompagnata da un’ossessione anticomunista che si manifestò anche durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ironia della sorte, al termine della guerra, molti collaborazionisti dell’Asse (italiani in Macedonia occidentale, bulgari in Tracia e Macedonia orientale) finirono con l’unirsi alla guerriglia comunista, il cui obiettivo era spartirsi il Paese con la Jugoslavia di Tito o realizzare una secessione a nord sotto la tutela bulgara. Questo epilogo, frutto di un secolo di irredentismo, generò un nazionalismo difensivo e, in parte, fondamentalista, secondo il quale la Grecia era circondata da nemici e nessun territorio poteva essere sacrificato.
Per comprendere meglio questo passaggio dal nazionalismo espansivo a quello difensivo, è essenziale analizzare i fattori che portarono all’indipendenza greca. Da un lato, l’insorgenza popolare spontanea venne strumentalizzata dalle potenze dell’epoca per perseguire i propri obiettivi geopolitici, tra cui il principale era indebolire l’Impero ottomano.
In primo luogo, è imprescindibile affrontare il tema del “rinascimento ellenico” o “illuminismo greco”, che rappresenta l’ideale sovrastrutturale alla base del processo di autonomia. Questo movimento si focalizza sull’invenzione linguistica di Adamantinos Korais (1748-1833) – ovvero la già menzionata katharevousa – concepita per minimizzare le variazioni del greco bizantino e ottomano al fine di creare una versione modernizzata del greco antico. Questa creazione linguistica, parte di quella che è definita la “questione della lingua greca”, divenne ufficiale nel nuovo Stato in sostituzione del greco popolare (dhimotiki), ma rimase confinata esclusivamente agli atti ufficiali, conservando oggi la sua funzione soprattutto nella Chiesa ortodossa greca dopo che la lingua popolare ha assunto lo status ufficiale a seguito della fine del regime dei colonnelli.
Accanto a questo fervore culturale, si svilupparono diverse società segrete animate dal sogno di rinascita dell’Impero bizantino, un’idea che fu a lungo presente nella mente della zarina Caterina II. Il suo “progetto greco”, dopo la conquista russa della Crimea (un’antica periferia bizantina), si fondava proprio sull’istituzione di Bisanzio sotto il controllo diretto di San Pietroburgo, con lo scopo di assicurare a Mosca il dominio sul Bosforo e sui Dardanelli.
La scintilla che scatenò la guerra d’indipendenza si innescò però all’interno dell’Impero ottomano: la ribellione di Ali Pasha a Ioannina costrinse l’esercito ottomano a intervenire in Epiro, lasciando altre regioni quasi senza difese (Morea, Tessaglia e alcune isole ionie). È curioso rilevare come il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, legato alla Sublime Porta, condannò inizialmente la rivolta greca. Solo dopo le atrocità commesse contro i sacerdoti, la Chiesa ortodossa locale decise di schierarsi a fianco dei ribelli, aprendo la strada alla futura autocefalia della Chiesa ortodossa greca rispetto al Patriarcato.
Come già accennato, la ribellione fu ispirata dal neoclassicismo e dal romanticismo diffusi in tutta Europa. L’obiettivo dei rivoluzionari era liberare la Grecia per farle riacquisire la propria autentica identità. Fondamentale in questo processo fu il ruolo della diaspora greca in Europa, che contribuì a trasformare la rivolta in una “guerra di civiltà” e a fare della questione greca un problema europeo. Da parte sua, l’Impero ottomano agevolò tale dinamica: il massacro di Chios nel 1822 e l’assassinio del patriarca Gregorio V a Costantinopoli, abbandonato dalle autorità, suscitarono profonda indignazione nell’opinione pubblica europea, alimentando il sostegno alla causa greca. Alla fine, l’indipendenza fu conseguita grazie all’intervento a tre (Francia, Gran Bretagna e Russia), ognuna con interessi specifici, ma unite nella volontà di utilizzare la Grecia come strumento per controllare da vicino l’Impero ottomano e porre fine a un conflitto durato un decennio.
Va altresì considerato che la questione greca si sviluppò nel contesto della Restaurazione e della Santa Alleanza in Europa, caratterizzata da protagonisti conservatori. Ioannis Kapodistrias, già ministro degli esteri di Russia zarista, non nutriva grande simpatia per l’estremismo della “Società dei Fratelli”, la forza dietro la rivolta indipendentista. Alexandros Ypsiliantis, colui che annunciò la rivoluzione, apparteneva all’élite commerciale greco-ottomana detta “fanariota”, proveniente dal quartiere Fanari di Costantinopoli, ed aveva ricoperto incarichi importanti nell’esercito dello Zar.
Dopo un iniziale atteggiamento dubbioso, i britannici nel 1824 concessero un prestito al governo rivoluzionario greco. La Francia, invece, si unì alle altre potenze mentre continuava a modernizzare l’esercito dell’ambizioso vice-Re d’Egitto Muhammad Ali, di origine albanese, che causerà ulteriori problemi alla Sublime Porta dopo il conflitto greco.
La battaglia navale di Navarino nel 1827, opposta alle flotte ottomane, segnò un punto di svolta cruciale nel conflitto. L’anno successivo, Kapodistrias divenne capo del governo greco, ruolo che svolse fino al suo assassinio nel 1831. Al suo arrivo si trovò ad affrontare una situazione complessa, con il Paese in mano a signori della guerra e mercenari (slavi e albanesi) che si vendevano al miglior offerente.
Nonostante ciò, le trattative tra le potenze e l’Impero portarono alla costituzione di un nuovo Stato, la cui corona fu affidata alla casa bavarese dei Wittelsbach. Si trattava di un’entità con 700.000 abitanti, economicamente devastata, mentre circa due milioni di greci restavano al di fuori dei suoi confini.
La nuova dinastia introdusse un esercito tedesco, burocrati e risorse finanziarie, ma il desiderio di stabilità – consolidato dal compromesso con il Patriarcato ecumenico del 1850 che mantenne l’unità dogmatica pur separando politicamente le due Chiese ortodosse – dovette fare i conti con le milizie irregolari attive nelle regioni settentrionali almeno fino alle Guerre Balcaniche del 1912-13. Questi gruppi, peraltro, erano funzionali a entrambe le parti: da un lato, agli ottomani per dimostrare che la Grecia non era ancora pronta a far parte del sistema di sicurezza europeo e per permettere ai signori locali di ottenere fondi e armi; dall’altro, allo Stato greco che li tollerava perché, concentrato sull’idea di liberare i greci rimasti fuori dai confini, riusciva a mantenerne il controllo, inglobandoli in seguito in polizia e esercito.
Le dinamiche politiche interne riflettevano le influenze delle potenze che avevano supportato la causa greca. I conservatori, come l’eroe dell’indipendenza Theodoros Kolokotronis e il fratello di Kapodistrias, erano filorussi. Konstantin Leont’ev, pensatore e diplomatico russo, ritenuto precursore dell’eurasismo, sostenne che aprirsi all’Occidente significasse perdere l’anima tradizionale della Grecia. I liberali invece guardavano a Gran Bretagna e Francia. Nel campo liberal, prevaleva una politica centrista guidata da Ioannis Kolettis, che prometteva prosperità, sviluppo e ampliamento dei confini, ma che nella pratica non realizzò nulla di significativo. Inoltre, dovette affrontare una crisi economica profonda – sorprendentemente, mentre l’Impero ottomano vantava una classe mercantile greca, la Grecia ne era priva – e l’incapacità di portare avanti una reale distribuzione fondiaria. Con il peggioramento dei rapporti tra le potenze e l’approssimarsi della Guerra di Crimea, Francia e Gran Bretagna spinsero la Grecia ad avvicinarsi all’Impero ottomano, distanziandola dall’influenza russa. In questo contesto, la crescita del panslavismo in Russia fu accompagnata da una crescente slavofobia in Grecia, anche su pressione britannica, con l’obiettivo primario di “sanificare” i confini settentrionali. La regione, patria di Filippo e Alessandro Magno, veniva considerata vitale per l’esistenza, la sicurezza e lo sviluppo della Grecia. Davvero curioso che i greci fossero stati i primi a definire “slavi macedoni” i bulgari slavizzati che abitavano parte di questo territorio, dando inizio a una delle più problematiche questioni etnico-culturali con i vicini che perdurerà fino ai primi decenni del XXI secolo.
Nel 1862 re Otto I abdicò e la sua dinastia fu sostituita da quella danese dei Glucksburg. Otto era divenuto capro espiatorio di tutti i guai del Paese. Prima dell’intervento di Francia e Gran Bretagna contro la Russia nel Mar Nero, aveva sperato di guidare una “seconda guerra di liberazione” contro l’Impero ottomano, rimanendo però deluso dai suoi “protettori”. Il nuovo sovrano Giorgio I si dimostrò politicamente più abile e, nel 1864, ottenne dalla Gran Bretagna la cessione delle isole ionie, acquisite durante le guerre napoleoniche. Nel 1881, dopo una lunga negoziazione, la Grecia ottenne la Tessaglia dall’Impero ottomano, ampliando il suo territorio del 26% e la popolazione del 18%. Questo risultato derivò dalla crisi orientale del 1878 (nuovo conflitto russo-ottomano) e dalla Conferenza di Berlino, in cui Francia, Gran Bretagna e Germania tentarono di contrastare la vittoria russa e le conseguenze del Trattato di Santo Stefano.
Nel 1896 un’ennesima rivolta anti-ottomana sull’isola di Creta spinse la Grecia a intervenire con truppe e aiuti. Nel 1897, tuttavia, l’esercito greco incassò una dura sconfitta in Tessaglia per mano delle forze ottomane, addestrate ed equipaggiate dalla Germania. L’alleanza tedesco-ottomana si stava rapidamente consolidando, come dimostra, per esempio, l’ambizioso progetto della ferrovia Berlino-Baghdad – contrastato dai britannici – mentre la Sublime Porta sponsorizzava la causa bulgaro-macedone, spingendo il Patriarcato ecumenico a riconoscere l’autocefalia della Chiesa bulgara, in opposizione ad Atene, e favorendo la nascita dell’Organizzazione Rivoluzionaria Interna della Macedonia. A ciò si aggiungeva l’allarme inglese per la costruzione della flotta militare tedesca, vissuta come una minaccia esistenziale all’Impero britannico. Queste tensioni si riflettevano nella politica interna greca, dove le divisioni tra monarchici filotedeschi e filobritannici si contrappondevano alle tendenze “occidentali” della classe politica liberale.
Nel 1909 la Lega Militare attuò un colpo di Stato denunciando l’eccessiva influenza monarchica sull’esercito e la diffusa corruzione politica. I giovani ufficiali, formatisi all’Accademia militare di Atene, chiamarono come consigliere politico l’avvocato cretese Elefterios Venizelos, che avrebbe avuto un ruolo centrale nella storia greca per il decennio successivo e oltre.
Venizelos, una volta al potere, sostenne un’agenda riformista e introdusse importanti modifiche costituzionali mentre esplodeva un nuovo conflitto nei Balcani. Questo fu provocato principalmente dalla debolezza dimostrata dall’Impero ottomano nella guerra italo-turca del 1912, che portò Roma a conquistare la Libia (anche se solo negli anni ’30 il regime fascista riuscì a sottomettere definitivamente la colonia, reprimendo la ribellione della Senussia guidata da Omar al-Mukhtar). Serbia, Bulgaria e Grecia, inaspettatamente alleate, colsero così l’occasione, soprattutto perché l’Impero si trovava alle prese con le conseguenze del colpo di Stato dei “Giovani Turchi” e con successive crisi e mutamenti istituzionali.
In questa fase il principale obiettivo greco era la conquista di Salonicco, città cosmopolita abitata all’epoca da 61.500 ebrei, 50.000 cristiani ortodossi e 45.000 musulmani, oltre che centro commerciale strategico nella regione. I maggiori successi greci arrivarono però in ambito navale, con la flotta che raggiunse la supremazia sull’Egeo bloccando i rifornimenti alle truppe ottomane e obbligando la flotta della Sublime Porta a rifugiarsi oltre gli Stretti.
Grecia, Serbia e Bulgaria stabilirono poi i rispettivi confini attraverso trattati bilaterali, nonostante l’Organizzazione Rivoluzionaria Interna della Macedonia avesse intenzione di continuare la lotta armata contro gli alleati.
Le guerre balcaniche del 1912-13 sono spesso viste come il preludio inevitabile alla “Grande Guerra”, così come il conflitto civile spagnolo fu l’anticipazione della Seconda Guerra Mondiale. Questa interpretazione è fondata considerando il coinvolgimento diretto o indiretto delle grandi potenze europee, come la “Triplice Intesa” interessata allo smantellamento dell’Impero ottomano, con una Gran Bretagna che mirava a controllare maggiormente il Vicino Oriente, e le tensioni fra Serbia e Impero austro-ungarico, quest’ultimo alle prese con pesanti problemi interni. Inoltre, le guerre balcaniche intensificarono le persecuzioni dei greci in Asia Minore, avviarono gli scambi di popolazione tra Grecia e Impero ottomano e posero le basi per lo “scisma nazionale greco” (dichasmos), aggravato dall’assassinio di Giorgio I e dalla salita al trono del figlio Costantino, già protagonista dei conflitti in Macedonia ed Epiro.
I primi scambi di popolazione generarono forti tensioni interne fra i nuovi arrivati e i “nativi”, specialmente fra l’élite conservatrice del Peloponneso, contraria a condividere il potere e i privilegi acquisiti in quasi un secolo di indipendenza. Questa contrapposizione si intensificò con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e le divergenze tra Venizelos e il sovrano: il primo favorevole a entrare in guerra al fianco dell’Intesa (con promesse, da parte dell’ambasciatore britannico, di cessioni territoriali in Asia Minore e Cipro, mentre Venizelos stesso richiedeva Smirne e territori limitrofi, isole dell’Egeo, nord dell’Epiro e Tracia), il secondo (filotedesco) propenso a una posizione neutrale.
Lo scontro rappresentava anche il conflitto tra due visioni contrastanti: i liberali di Venizelos, ancora legati alla “Megali Idea” della liberazione di tutte le comunità elleniche dal giogo ottomano; e i conservatori monarchici, che sostenevano una “Grecia ridotta territorialmente ma comunque dignitosa”. Costantino e i suoi sostenitori ritenevano infatti che entrare nel conflitto fosse inutile, favorendo solo le ambizioni espansionistiche della Serbia.
Lo “scisma nazionale” tra monarchia e governo parlamentare venne ulteriormente alimentato dall’Intesa, che minacciò di cedere Salonicco e la Macedonia alla Serbia qualora la Grecia non si fosse impegnata direttamente nel conflitto. Questi episodi e le ripetute violazioni territoriali spinsero Venizelos e alcuni ufficiali a creare un governo parallelo a Salonicco per sostenere lo sforzo bellico al fianco di Francia, Gran Bretagna e Italia sul fronte macedone, mossa non apprezzata dai britannici, preoccupati per il crescente legame tra Venizelos e la Francia.
Così la Grecia si ritrovò divisa, separata da una zona neutrale, mentre Venizelos continuava a sollecitare all’Intesa il permesso di marciare su Atene. Il suo ritorno nella capitale fu segnato dalla dura repressione degli elementi filo-monarchici e dalle pressioni su Costantino, che fu costretto ad abdicare a favore del figlio Alessandro e a lasciare il Paese a bordo di un incrociatore britannico.
Al termine del conflitto, benché si trovasse in una grave crisi politica interna, la Grecia prese parte al tavolo dei vincitori con la convinzione che l’armistizio di Mudros legittimasse la sua espansione verso Anatolia. Sulla base della Conferenza di Parigi, del Trattato di San Remo e di quello di Sevres (quest’ultimo volto a proteggere i gruppi etnici all’interno dell’ex Impero ottomano), Smirne divenne protettorato greco per cinque anni. Al termine di questo periodo, la città avrebbe dovuto scegliere il proprio destino tramite referendum. Al momento dell’ingresso delle truppe greche (15 maggio 1919), la regione ospitava 620.000 greci e 950.000 turchi.
La situazione mutò rapidamente nel 1920: dopo la sconfitta alle elezioni parlamentari dei liberali di Venizelos e il ritorno in Grecia di Costantino – sotto la protezione britannica, dopo la morte improvvisa del figlio Alessandro – i britannici credevano di poter usare la loro influenza per controllare gli Stretti. Parallelamente, i militari greci cercarono di impressionare Londra dichiarandosi capaci di soffocare quasi subito la rivolta nazionalista guidata da Mustafa Kemal, la cui ambizione era realizzare uno Stato turco etnico entro i confini anatolici, ostacolando quindi la spartizione del territorio.
La Grecia inviò così in Turchia un contingente di 200.000 uomini con l’idea, persino, di assediare Ankara, sede dell’assemblea nazionale kemalista. Tuttavia, dovette rapidamente ritirarsi di fronte a un esercito che impiegava sia forze regolari sia tattiche di guerriglia e azioni asimmetriche. Inoltre, Francia e Italia, teorici alleati di britannici e greci, iniziarono a tessere rapporti col governo nazionalista turco e con i bolscevichi russi. Questi ultimi, preoccupati dalla presenza britannica sugli Stretti, fornirono supporto militare ai kemalisti, considerando “venizelismo” e “Megali Idea” espressioni di imperialismo.
Il tentativo greco di assediare Istanbul per esercitare pressioni su Mustafa Kemal indebolì ulteriormente il fronte asiatico, che venne spezzato dalle forze turche nell’estate del 1922. Seguirono l’abbandono graduale del progetto greco da parte dei britannici e la terribile catastrofe di Smirne, quando milizie irregolari – desiderose di vendetta per il tradimento greco durante la Prima Guerra Mondiale – gettarono in mare la popolazione ellenica, prima dell’ingresso nell’area urbana dell’esercito di Ataturk.
Il Trattato di Losanna, sancendo un nuovo scambio di popolazioni, pose fine non solo all’espansionismo della “Megali Idea” ma anche a secoli di convivenza pacifica fra diverse etnie e confessioni in Asia Minore.
In chiusura di questa prima parte, è importante sottolineare come la storia e la geopolitica della Grecia nel suo primo secolo abbiano seguito un’idea di rinascita nazionale, influenzata però da volontà esterne che spesso si contrapponevano anche tra alleati come Francia e Gran Bretagna, influenzandone chiaramente le direzioni politiche. Dopo la fine della guerra in Asia Minore, la Grecia si trovò a confrontarsi con nuove minacce esterne (come l’Italia fascista) e interne (il timore per il bolscevismo).